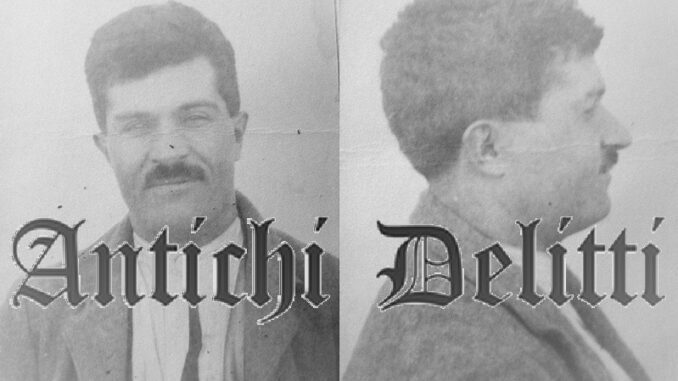
È la notte tra il nove e il dieci luglio 1925 quando uno scalpiccio di zoccoli di cavalli e il contemporaneo abbaiare dei cani sveglia la famiglia Barca. Bernardo, il settantacinquenne patriarca, accende il lume e guarda l’orologio: la mezzanotte è passata da pochi minuti. Si svegliano anche i figli Gaetano, quarantasette anni, Vincenzo, quarantasei anni, Amalia, quarant’anni e tutti gli altri familiari e domestici presenti quella notte nel casino di campagna posto in contrada Macchia, qualche chilometro più su dell’abitato di Serra Pedace.
– Michele! Michele! – urla Vincenzo all’indirizzo del loro lavorante Michele Feraca, uscito con un cavallo e una giumenta tre giorni prima per andare a fare legna in contrada Dirroiti e mai più rientrato. Tutta la famiglia Barca si sente ora sollevata, l’uomo, per il quale hanno temuto, è tornato e con lui gli animali. Ma quando gli animali sono fiocamente rischiarati dalle lanterne, tutti cadono di nuovo nello sconforto: Michele non è con loro. Vincenzo, il quale conosce bene il carattere del lavorante, continua a chiamarlo – Michele, esci e non temere, non fa niente se sei mancato tre giorni.
Ma ogni sforzo è vano, Michele non risponde. Ci sono solo i due animali con tutti i finimenti a posto, eccezion fatta per una fibbia che manca.
Michele Feraca ha cinquant’anni e lavora da molti anni per conto dei Barca che lo tengono in grande considerazione per la sua onestà e segretezza, anche se quando ripensa alla moglie rimasta in Sud America gli vengono degli attacchi di depressione e, credendola nel suo paese natale, se ne va a Feruci a cercarla.
Dove può essere Michele? La mattina dell’otto luglio don Vincenzo gli ordina di preparare il cavallo, la giumenta e due buoi per andare in contrada Dirroiti dove hanno una carboniera data in fitto ai fratelli Pasquale e Vincenzo Bendicenti. Michele si fermerà in zona a far due some di legna, mentre don Vincenzo proseguirà verso un’altra proprietà dove la ditta Petrella sta tagliando tronchi per farne delle travi e per far ferrare i buoi da mastro Pasquale Bonanno alla Funicolare Petrella.
Don Vincenzo, terminato il suo da fare, torna a casa nel primo pomeriggio e già comincia a preoccuparsi per il mancato rientro di Michele, così torna indietro a cercarlo, mentre suo fratello Gaetano scende in paese per vedere se sia andato a casa della madre. Non è in nessuno dei due posti e, ormai sera, i Barca si ripromettono di continuare le ricerche l’indomani mattina, ma le ricerche sono infruttuose e così, prima che faccia sera, don Vincenzo va dai Carabinieri di Pedace a fare la denuncia per la scomparsa.
Quando il cavallo e la giumenta tornano da soli, la preoccupazione che possa essere accaduta qualcosa di brutto aumenta, ma corrono voci che vorrebbero Michele in Sila a cercare lavoro come mugnaio, la sua vecchia occupazione, e voci che lo dicono diretto in paese, dove, per altro, non è mai arrivato. I Barca seguono a ritroso le impronte che i cavalli hanno lasciato nel grano e si accorgono che vengono dalla montagna e non dal paese. Gli è chiaro, a questo punto, che Michele deve essere da qualche parte nei boschi.
La mattina del dieci luglio in contrada Dirroiti ci va anche il settantenne Santo Leonetti col suo asino. Ad un certo punto si accorge che l’asino si è allontanato e lo va a cercare. Vede il mulo sul ciglio di una scarpata al di sotto di un sentiero e lo raggiunge. La sorpresa è di quelle che lasciano senza parole: a un paio di metri dall’asino giace, su di un lato, il corpo quasi decapitato di un uomo con una scure in mezzo alle gambe! Santo Leonetti non si pone nemmeno il problema di chi possa trattarsi, prende l’asino per le briglie, torna dove ha lasciato la legna, la carica sull’animale e se ne va. Fa solo pochi metri quando, accanto al guado di un torrente dove ci sono le baracche occupate dai fratelli Bendicenti, incontra la loro madre, Vincenzina Serafini:
– C’è un morto a cento metri da qui, ma io non so chi sia – le dice.
– È il cavallaro di Barca, vado a dirlo ai padroni – gli risponde senza scomporsi.
La donna si incammina verso la casa dei Barca e quando arriva trova donna Amalia:
– Buongiorno, don Vincenzo dov’è? – le chiede.
– Che è successo? – risponde donna Amalia preoccupata.
– Michele…
– È morto?
– Si, è dentro un vallone, prendete una coperta che se l’hanno mangiato le mosche, tiene una piaga cagionata dalle mosche – spiega mentre donna Amalia scoppia a piangere, poi continua – Era solito pigliargli qualche malore?
– In verità, no; solo qualche volta soffriva di mal di pancia, ma con una tazza calda di lauro tutto finiva! – Vincenza la ascolta pensierosa e poi, dopo un silenzio che sembra interminabile, dice in modo sibillino:
– Bè, io per coscienza ve lo faccio il testimone… – donna Amalia non capisce il senso di quelle parole ma non se ne fa un problema, è troppo angustiata per la sorte toccata al fido Michele. Vincenza, dopo qualche altro secondo di silenzio, conclude – Io non sarei venuta a riferirvi il rinvenimento del cadavere, ma a tanto sono stata indotta perché ho saputo che le cavalcature sono ritornate…
Don Vincenzo, avvisato della tragica notizia, sta per precipitarsi sul posto, ma il padre lo blocca ordinandogli di scendere a Pedace per avvisare i Carabinieri. A contrada Dirroiti andrà egli stesso accompagnato da Vincenza, alla quale fa portare una coperta, e dal suo bovaro Pasquale Rota.
La vista del cadavere non è di quelle che si possano scordare facilmente: nella larghissima ferita triangolare che ha quasi decapitato il povero Michele, chiaramente prodotta da un poderoso colpo di scure, entrano ed escono insetti di ogni tipo. La bocca, il naso, le cavità orbitali e le orecchie sono invase dai vermi che brulicano dappertutto, ricoprendo anche la camicia e il panciotto. Molto del tessuto connettivo della testa non esiste più perché putrefatto.
Fatto coprire il cadavere, don Bernardo nota lo strano atteggiamento dei fratelli Bendicenti che si trovano a pochi metri, perché è proprio a una cinquantina di metri dal cadavere che arde la carboniera data loro in fitto: Pasquale Bendicenti è completamente disinteressato a ciò che sta accadendogli accanto, mentre suo fratello Michele osserva la scena dall’alto del sentiero senza proferire parola.
“Perché?” si chiede don Bernardo.
Quando sul posto arrivano il Pretore di Spezzano Grande, Luigi Pace, e il Vicebrigadiere Federico Verni, comandante della stazione di Pedace gli fa notare questa singolare circostanza. In effetti è molto strano che i fratelli Bendicenti e la loro madre non si siano accorti di nulla a così pochi metri di distanza e quando è chiaro che non si è trattato di una disgrazia, diventano i principali indiziati per l’omicidio di Michele, o quantomeno che tutti e tre debbano essere a conoscenza di fatti che potrebbero fare individuare l’assassino. Si, perché, così ragionano gli inquirenti stando ai fatti finora accertati, l’ultimo ad aver visto vivo Michele Feraca è don Vincenzo Barca e quindi non si può non considerarlo come possibile autore del delitto. Una cosa però è certa: chi ha ucciso Michele Feraca lo ha colpito all’improvviso senza dargli il tempo di impugnare la rivoltella che gli investigatori trovano regolarmente inserita nella fondina appesa alla cintura dei pantaloni del cadavere.
I fratelli Bendicenti, la loro madre e don Vincenzo Barca finiscono nel carcere di Colle Triglio e avranno il loro bel da fare per tirarsi fuori dai guai.
Per don Vincenzo la cosa è più semplice: per lui parlano gli anni di confidenza col povero Michele e molti testimoni che giurano sull’affetto verso di lui e sulla sua incapacità a delinquere. Ma, d’altra parte, basterebbe come movente la voce che avrebbe voluto Michele in procinto di lasciare il lavoro per cercarsene un altro come mugnaio a giustificare l’omicidio? Francamente no e il Giudice istruttore dopo pochi giorni lo rimette in libertà.
E per la famiglia Bendicenti che movente ci potrebbe essere a giustificare tanta brutalità? Forse il contrasto sopraggiunto per il taglio della legna, perché quella legna serviva per alimentare la carboniera e quindi lo scatto d’ira omicida di uno dei due fratelli. Ma questa tesi è facile da smontare: Michele stava tagliando e raccogliendo legna secca, mentre per fare il carbone ci vuole legna verde. Allora dov’è il movente per tenerli in carcere? Ci vuole una proroga, al momento non si trovano prove certe, anche se è evidente che ci debbano essere dentro fino al collo.
Poi, finalmente, la svolta: qualcuno all’improvviso ricorda che Pasquale Bendicenti è stato ricoverato nel manicomio di Nocera Inferiore fino a pochi mesi prima del delitto. È chiaro adesso?
Michele Bendicenti capisce che se non vuota il sacco per lui e la madre saranno guai molto seri e il quattordici luglio, interrogato, rivela:
– Quando tornai in contrada Dirroiti, il mattino di mercoledì otto corrente, non trovai mio fratello Pasquale. Sopraggiunse solo verso le undici, reduce dall’Acerina: aveva la giubba estiva nuova, portava due ricotte e mi disse di averle comprate in quella contrada da Alessandro Oliverio. Gli chiesi perché non avesse portato l’erba per l’asino e lui mi rispose: Non mi sentivo bene e l’idea non mi ha aiutato. Notai che era sconvolto ed eccitato e così si è mantenuto fino a che non andammo a letto, ma non gliene chiesi il perché. Mentre dormivamo si svegliò all’improvviso come indemoniato, prese la sua scure tagliente e mi si avventò contro dicendo: Ajo acciso a chillo ed ai murire puru tu! Cercai di rabbonirlo e fui salvo per la mia prudenza. Siccome lo sapevo un forsennato non indagai, credendo che fosse una delle sue solite escandescenze, perché altre volte ha minacciato di morte me e mia madre, tanto che è stato dimesso a marzo scorso dal manicomio di Nocera Inferiore. Sicuramente ha cambiato la giubba dopo avere ammazzato Feraca per allontanare i sospetti e non ho fatto caso se la scure con la quale mi minacciò fosse sporca di sangue ma, di certo, se ha pensato a cambiare la giubba, avrà senz’altro pensato a lavare l’arma. La colpa di tutto è di mia cognata, la moglie di Pasquale, perché credendo che fosse guarito dall’alienazione mentale, fece pratiche in reiterazione per farlo dimettere dal manicomio! Per farvi capire il suo stato, vi dico anche che il giorno dopo, giovedì, mentre lavorava con me nelle vicinanze della carboniera, all’improvviso montò su tutte le furie e si avventò di nuovo contro di me urlando: Devi morire pure tu! Poi, vedendo venire verso di noi i buoi guidati da Pasquale Rota, si scagliò contro gli animali brandendo la scure per ammazzarli e per poco non lo fece davvero. Quando fu ritrovato il cadavere di Michele Feraca ucciso in quel modo orrendo, capii che era stato davvero lui e cercai di farmi spiegare il motivo per cui aveva fatto quella cosa e lui, sempre più cisposo, mi fece intendere che forse, essendosi impariolato col Feraca, il quale gli avrebbe domandato dove fossero le giumente, egli, preso da una solita crisi nervosa, lo avrebbe ucciso con un colpo di scure al collo. Mio fratello ha fatto l’artigliere e niente di più facile che, mentre il povero Feraca raccattava la legna, dovette montare sulle bestie e portarle verso l’Acerina, donde la lite tra i due, degenerata in grave delitto. Quando fui fermato dai Carabinieri, feci vedere al Brigadiere le tre scuri e lui fece dei segni col lapis sulle aste e la piccola, la più tagliente, quella che dovette servire al delitto e che mio fratello usava sempre portare seco, i prefati militi, con somma leggerezza, gliela lasciarono seco. Ora, se i Reali Carabinieri non furono previgenti di sequestrarle ed assumono di non averle rinvenute sopra luogo, io nulla posso dire perché, ripeto, essendo stato tradotto nella camera di sicurezza di Pedace e poi in questo carcere, non posso dire e se ad opera di chi fossero state nascoste o trafugate. Mio fratello ebbe le prime crisi l’anno scorso, proprio nei primi giorni di luglio e poi siamo stati costretti a farlo rinchiudere.
Le cose sembrano cominciare a chiarirsi. Ma Pasquale confesserà di essere l’autore dell’orrendo delitto o il fratello sta tentando di scaricare la responsabilità sul pazzo?
– Non so resistere alle vostre esortazioni e confesso di aver ucciso con un colpo di scure al collo il mulattiere Feraca Michele verso le ore sette del mattino di mercoledì otto luglio in contrada Dirroiti, dove mi trovavo solo intorno alla carboniera. Mio fratello Michele e mia madre mi raggiunsero più tardi ma io nulla dissi loro del delitto commesso. Mentre badavo alla carboniera, Feraca mi chiamò per farsi aiutare a tagliare la legna. Io andai e mentre lo aiutavo lui mi rimproverò dicendomi che ero lento nel lavoro. io gli risposi: Invece di ringraziarmi, mi rimproveri pure? E siccome lui alzò la scure verso di me montai su tutte le furie e per difendermi gli assestai un colpo al collo e lui cadde all’istante cadavere. In verità egli, pur avendo la rivoltella non la usò punto contro di me, imbrandendo solo la scure quando mi si avventò contro. Poi ebbi cura di lavare la scure sporca di sangue nella vicina fiumara e quando la mostrai al Brigadiere non si accorse di nulla e me la lasciò a disposizione per alimentare la carboniera.
È fatta! Il colpevole ha confessato e non c’è più motivo di tenere in carcere la madre e il fratello Michele. Ma adesso c’è da chiarire se Pasquale, come sostengono tutti, Pubblico Ministero compreso, sia o meno capace di intendere e volere, visti i suoi recenti trascorsi. Avviata la pratica per la perizia psichiatrica, il 2 ottobre 1925, Pasquale Bendicenti viene internato nel manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto e affidato alle cure dei dottori Emanuele Mirabella e Franco Cammarata.
– Io contrassi la malaria sul Piave durante l’ultima guerra Nazionale e, congedatomi nel dicembre 1919, fui curato dal dottor Scarnati di Serra Pedace e dal dottor Ferraro di Paola, i quali mi fecero parecchie siringhe ipodermiche e mi somministrarono l’Esanofele. Nel luglio 1924 fui ricoverato nel manicomio di Nocera Inferiore da dove fui dimesso nel marzo 1925 – Pasquale si presenta ai due periti, i quali chiedono ai medici curanti notizie sulla storia familiare dell’imputato per verificare una eventuale tara genetica.
Così Mirabella e Cammarata scoprono precedenti morbosi di grande rilievo e tutti di natura nevropatica: un cugino ed uno zio materno di Pasquale sono morti in manicomio; la madre presenta chiare note di deficienza psichica; una sorella soffre di epilessia e lo stesso fratello Michele, dopo avere ucciso il proprio padre a bastonate, è stato internato per diciotto mesi nel manicomio di Nocera Inferiore per alienazione mentale; uno zio paterno era sordomuto e, infine, un figlioletto di Pasquale è morto per eclampsia. Scoprono anche che la forma malarica di cui si è ammalato Pasquale è la peggiore, quella che si ripresenta ogni anno tra l’estate e l’autunno e che richiede formidabili dosi di chinino per attenuarne i sintomi. Scoprono anche che la domenica precedente all’omicidio Pasquale tornò in paese per partecipare a una festa di matrimonio dove bevve parecchi bicchierini di liquore che gli causarono, durante la notte, agitazione e un insolito eccitamento sessuale.
I periti, osservando le caratteristiche morfologiche di Pasquale notano qualcosa che potrebbe essere decisiva per il giudizio finale: Le orecchie piccole col lobulo aderente presentano superiormente bene apprezzabile il tubercolo di Darwin[1], specialmente evidente a destra. All’angolo tra la branca smontante della mandibola destra con la branca orizzontale, si percepisce bene la presenza dell’apofisi lemuriana[2]. Questo carattere ed il tubercolo di Darwin sono caratteri pitecoidi propri dei primati antropomorfi. Quasi una scimmia.
Quando Mirabella e Cammarata passano a formulare le loro considerazioni medico-legali non possono fare a meno di constatare che: Ci son pazzi, anomali e neuropatici negli ascendenti, nei collaterali, nei discendenti ed il significato di questo quadro ereditario non può essere dubbio perché non rappresenta un semplice indizio isolato che potrebbe venire interpretato come una eccezione, una deviazione sporadica di un unico ramo da un albero diritto, una coincidenza. Qua siamo di fronte a svariate manifestazioni di un unico fatto, siamo di fronte ad una famiglia degenerata, di cui ogni membro porta manifesta una deficienza, od una anomalia a carico del sistema nervoso. Il Bendicenti infatti che fino ad una certa età aveva portata discretamente celata la sua inferiorità, che aveva discretamente condotta la navicella della sua vita, era un “minus valor” non rivelato; occorreva un reagente per mettere in luce lo scarso valore bio-metabolico del suo sistema nervoso.
Molto probabilmente non sarà stato unico il reagente, come ordinariamente mai unica è la causa delle malattie mentali; certo però nella cooperazione dei diversi fattori nel nostro caso la malaria rappresenta un ruolo di primaria importanza.
La malaria estiva-autunnale, continuano, è la forma più maligna, la più resistente alle cure, la più tenace, quella che dà gli accessi di perniciosa tanto pericolosi, tanto deleteri per l’organismo, tanto proteiforme nelle manifestazioni e nelle localizzazioni di cui una delle più frequenti è quella del sistema nervoso. Una infezione così lunga e così grave, con notevole tendenza a ledere le funzioni nervose anche in soggetti integri, ebbe facilmente ragione di un organo congenitamente minorato.
E scoppiò violentemente un accesso confusionale con vaniloquio, incoerenza, allucinazioni multiple ecc.; sindrome che bene si individua e si classifica come amenziale.
L’amenza, altrimenti detta delirio sensoriale, è una psicosi acuta caratterizzata principalmente dall’atassia mentale, cioè dello stato confusionale più marcato, che coinvolge tutti i processi della percezione e della ideazione e trae costantemente origini da una perturbazione organica, tossica, o tossinfettiva palese il più delle volte, qualche volta non precisabile.
Il Bendicenti guarì e dopo un congruo periodo di osservazione necessaria per accertare la guarigione, venne dimesso dal manicomio di Nocera. Dopo un mese si ammalò di bronchite foetida, malattia esauriente che lo travagliò per circa due mesi (aprile e maggio); appena guarito si recò in montagna a far carbone e ben s’immagina quanto quella vita disagiata sia poco propizia per un convalescente.
Intanto la malaria lavorava. Eravamo nel luglio 1925, nello stesso mese cioè in cui nell’anno precedente si era avuta l’esplosione della psicopatia, le condizioni organiche che avevano dato luogo alla malattia mentale erano pressochè invariate, non mancava l’azione usurante della canicola e del lavoro pesantissimo; si aggiunse un abuso di sostanze eccitanti (vino, liquori) durante una festa nuziale, non ci meravigliamo se comincia a delinearsi il quadro di una ripresa della crisi amenziale già sofferta.
Bastò un piccolo incidente per determinare nel periziando un impulso alla violenza bestiale e poiché aveva a portata di mano la scure (strumento del mestiere) non esitò a vibrare un violentissimo colpo che per poco non separò il capo dal tronco della vittima.
Ma nel momento del delitto, chiedono i giudici ai periti, Pasquale Bendicenti era o non era capace di intendere e volere? Dopo i lunghi mesi di ricovero, è nelle condizioni di affrontare un processo in modo da potersi difendere dalle imputazioni?
Il Bendicenti, rispondono i periti, nel momento in cui commise il delitto era affetto da una lieve forma di “amenza” e la sua infermità mentale era tale da diminuire grandemente la sua imputabilità consentendogli, però, di assistere al dibattimento e provvedere alla sua difesa.
Mirabella e Cammarata fanno ai giudici un’ultima raccomandazione: la sua libertà diverrebbe pericolosa a sé e agli altri in caso di un nuovo accesso di psicopatia; per tale motivo si rende necessario un lungo periodo di osservazione, tenendo conto che da quando è entrato a Barcellona la mente di Pasquale ricuperò la sua lucidità e le sue azioni divennero quelle di un uomo normale, appena deficiente.
A questo punto Pasquale Bendicenti viene rinviato a giudizio per omicidio volontario e il dibattimento si svolgerà presso la Corte d’Assise di Cosenza il 2 febbraio 1927. Sarà condannato a 5 anni e 10 mesi di reclusione, di cui 2 anni condonati.
Poi tornerà a Barcellona Pozzo di Gotto.[3]
I CAMINANTI-Quando gli zingari rubavano galline
[1] Il tubercolo (o lobulo) di Darwin è un ispessimento dell’elice dell’orecchio. Si trova alla giunzione della terza parte superiore con la terza parte media. Benché si chiami “tubercolo di Darwin”, fu descritto per la prima volta dallo scultore inglese Thomas Woolner. L’ispessimento del tubercolo di Darwin può essere o verso l’esterno o verso l’interno. Questo nodulo cartilagineo è posizionato sul bordo esterno del padiglione e sembra essere un residuo dell’articolazione che permetteva ai nostri progenitori di muovere e orientare le orecchie. Il lobulo darwiniano era annoverato in passato tra i “caratteri degenerativi” della fisiognomica di Cesare Lombroso, ovvero quei tratti somatici indicatori di regressione evolutiva e collegati alla propensione criminale del soggetto che li esibiva. NdA.
[2] L’apofisi è una parte sporgente di un osso, una protuberanza. L’apofisi lemuriana è una sporgenza ossea all’interno della mandibola, anch’essa annoverata tra i “caratteri degenerativi” della fisiognomica di Cesare Lombroso. (NdA)
[3] ASCS, Processi Penali.

Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.