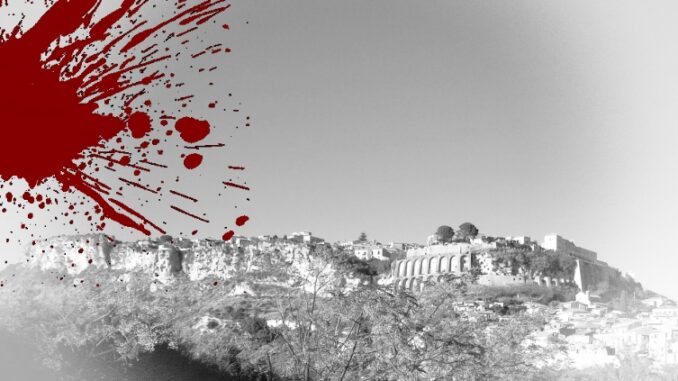
Domenico Staltari, quattordicenne da Gerace Superiore, è solito andare in giro per le campagne allo scopo di comprare piccole quantità di ulive per conto del padre, che poi rivende. La mattina del 24 novembre 1938 Domenico, durante uno dei suoi giri, incontra il venticinquenne pastore Salvatore Femia, noto ladruncolo soprannominato “lo storpio”, che gli vende tre litri di ulive per lire 2,40.
– Se vieni più tardi te ne vendo una maggiore quantità di migliore qualità, vai a prendere altro denaro, la maggiore somma possibile – dice al ragazzo.
Domenico accetta e corre a casa per farsi dare i soldi da suo padre, che gli dà altre 30 lire. Verso mezzogiorno, portando un sacco, un mezzo decalitro di lamiera di ferro e suonando un piccolo organetto ritorna da Femia in contrada Piani di Santa Caterina, dove sta facendo pascolare le pecore di suo fratello.
– Vieni con me, ho nascosto le olive qui vicino – gli dice Femia, portandolo in un fossato abbastanza largo sito ai piedi di un terreno scosceso. Arrivati sul posto, continua –. Prendi i soldi.
Mentre Domenico caccia dalla tasca il denaro gli cadono a terra delle monete e si china a raccoglierle. Lo storpio, veloce come un lampo, approfitta del momento e col bastone che ha in mano colpisce in testa Domenico, che stramazza al suolo. Poi estrae dalla tasca un coltello e, adoperando il braccio sinistro giacché il destro è in lui atrofizzato per emiplegia, gli vibra ben undici colpi in direzione del collo, della nuca e della schiena, uccidendolo all’istante.
Incurante del sangue che ancora zampilla tutto intorno, gli rivolta le tasche e si impossessa di tutto il denaro che trova, altre 23 lire. Poi adagia alla meglio il cadavere nel fossato, ricoprendolo con terriccio e pietre, getta nel sottostante burrone il mezzo decalitro e torna, come se niente fosse, a pascolare gli animali.
I genitori di Domenico sono preoccupati per il suo mancato ritorno a casa e si mettono a cercarlo senza ottenere risultati, spargendo in giro la voce della sparizione. Il giorno dopo alcuni ragazzi che stanno gironzolando dalle parti dove Domenico è stato ucciso, per caso trovano il mezzo decalitro e danno l’allarme, poi vanno a dare un’occhiata sul fossato, l’unico posto da dove il mezzo decalitro può essere stato lanciato, e fanno una macabra scoperta: dalla terra spunta un ginocchio umano piegato!
Immediatamente avvertiti, i Carabinieri di Gerace si precipitano sul posto e dissotterrano il cadavere di Domenico, poi cominciano ad indagare e scoprono subito che il ragazzo era stato visto in compagnia dello storpio e rinvengono nei pressi del fossato una serie di impronte di piedi che corrispondono a quelle di persona col piede destro storpio e scalzo e i sospetti su Femia, paralitico dal lato destro, aumentano. I Carabinieri vanno a casa sua e la perquisiscono, rinvenendo un bastone intriso di sangue, nonché la somma di ventitré lire nascoste in un fazzoletto, il sacco vuoto appartenente alla vittima e le ulive. È la conferma che ad uccidere Domenico è stato Salvatore Femia, che viene rintracciato e arrestato. Se ce ne fosse bisogno, un’ulteriore conferma viene dai suoi pantaloni imbrattati di sangue. Contestatigli tutti gli elementi a suo carico, prima nega, ma poi finisce per confessare:
– È vero, l’ho ammazzato io per impossessarmi del suo denaro… dopo ho pulito il coltello e sono tornato a casa, ho nascosto il denaro, il sacco e le ulive dove poscia sono stati ritrovati…
Omicidio premeditato a scopo di rapina, è prevista la pena di morte.
L’istruttoria viene chiusa rapidamente, Femia viene rinviato a giudizio e la causa si discute il 2 febbraio 1939 davanti alla Corte d’Assise di Locri.
La Corte, avendo constatato mediante diretta osservazione che l’imputato è affetto da emiplegia spastica destra, residuata a paralisi, ritiene necessaria una indagine sul suo stato di mente e affida la perizia psichiatrica all’alienista Professor Puca ed al Dottor Barillaro.
Tenuto in osservazione il periziando per un congruo periodo di tempo, il primo maggio 1939 consegnano la relazione, nella quale evidenziano che: 1) Femia Salvatore ha una emiparesi atrofico – spastica a destra, con coreoatetosi (La coreoatetosi è l’associazione di corea – ovvero movimenti a scatti molto rapidi – e atetosi – movimenti molto ampi e, nell’esplicarli, lenti –. Nda) ed accenni epilettici generalizzati e conseguente frenastenia da cerebropatia dell’infanzia. 2) Nel momento in cui commise il fatto erano in lui grandemente diminuite, se non abolite, le sue capacità di intendere e di volere, per cui, dai dati clinici e dall’esame del caso, ne deriva la semi infermità mentale.
La diagnosi che formulano è quella di epilessia non di natura degenerativa, ma di natura sclerotico – cicatriziale che lascia tracce profonde sulla intelligenza, sul carattere, sul comportamento e produce un difettoso sviluppo mentale, meglio definito come frenastenia morale ed intellettiva.
A spiegazione della loro indagine, affermano di esservi giunti dopo avere accertato che il Femia, nella sua prima infanzia, subì una encefalite grave che lasciò sulla corteccia centrale una profonda sclerosi, tanto profonda da impegnare persino i nuclei della base. Poi concludono: l’imputato ha nullameno dimostrato di avere un certo orientamento, una certa avvedutezza, una memoria precisa degli avvenimenti con disposizione a nascondere il delitto ed a creare una giustificazione. Il Femia, il quale sembra “un rottame morale”, non è del tutto minorato, né può definirsi un imbecille globale, ma è affetto da infermità mentale parziale.
La discussione della causa può riprendere il 30 novembre successivo e la Corte, letti gli atti ed ascoltati i testimoni e le parti, osserva: in base agli elementi di prova raccolti, è certo che Femia Salvatore è l’autore dei gravi delitti addebitatigli; non vi è dubbio che l’uccisione dello Staltari fu commessa a scopo di rapina della piccola somma; il fine omicida risulta dal mezzo adoperato – lungo ed acuminato coltello – dal numero dei colpi, ben undici, dalle regioni vitali attinte – collo e regione carotidea – dall’effetto letale immantinenti conseguito, nonché dalla gravità della causale. La conclusione della perizia sembra meritevole di essere pienamente accolta, sicché deve ritenersi che il giudicabile è ben responsabile dei reati ascrittigli, ma la sua responsabilità è grandemente scemata a causa di infermità mentale da cui egli era affetto (e lo è tuttavia) nel momento consumativo del reato. È inutile poi attardarsi per escludere la premeditazione, sia perché il fatto fu improvviso, senza adeguata preordinazione, e sia perché il vizio parziale di mente mal si concilia con detta aggravante, che richiede una maggiore intensità di dolo.
Si può passare a determinare la pena da infliggere all’imputato: la pena stabilita per l’omicidio a scopo di rapina (essendo nella specie evidente il rapporto di mezzo e fine tra i due reati) va sostituita, per effetto del vizio parziale di mente, con la reclusione da 24 a 30 anni. Tenuto conto della natura del fatto, del motivo a delinquere, dell’arma adoperata e, in particolar modo, del grado assai elevato di pericolosità dimostrato dal giudicabile, si stima giusto infliggere al Femia anni 26 di reclusione per l’omicidio aggravato ed anni 5 e mesi 6 di reclusione per la rapina. Cumulando, però, le pene detentive non si può superare il massimo legale della durata della reclusione, sicché in concreto si infligge la pena di anni 30 di reclusione, oltre alle spese, ai danni ed alle pene accessorie.
Ma la Corte non ha ancora finito: egli deve essere ricoverato in una casa di cura e custodia ed a tal uopo, avuto riguardo alla specie di affezione morbosa di cui soffre, sembra provvido disporre che il ricovero preceda l’espiazione della pena detentiva e si protragga per anni 10.
Tra una cosa e l’altra fanno 40 anni.
Il 6 novembre 1963 la Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro dichiara condonati mesi 6 della pena.[1]
[1] ASCZ, Sezione di Lamezia Terme, Sentenze della Corte d’Assise di Locri.